La tendenza all’aggregazione di nuovi poli imperialistici
La tendenza all’aggregazione di nuovi poli imperialistici – tendenza alla guerra e all’economia di guerra del capitalismo – green washing e l’ipocrisia di un’economia capitalista “sostenibile” – riflessi della crisi sul fronte interno, tendenza all’autoritarismo – repressione e D.D.L. 1660.
“Siamo gli ultimi a negare che esistano contraddizioni nel capitale.
Il nostro scopo è piuttosto quello di svilupparle appieno”
Karl Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica
E’ innegabile che lo scenario internazionale veda il progressivo allargamento e l’intensificazione dei conflitti bellici e che la possibile escalation militare verso la catastrofe mondiale sia molto più che un’ipotesi remota o uno scenario da narrazione distopica. Ciò in quanto tali dinamiche rappresentano, oltre che la diretta conseguenza, anche una costruita possibilità agita dal declinante imperialismo atlantista per una duplice finalità strategica: da un lato, per il possibile rilancio di cicli di accumulazione per economie fiaccate dalla crisi strutturale e, dall’altro, per cercare di indebolire, in un contesto sempre più multipolare e instabile, i propri antagonisti in consolidamento e rafforzamento. E’ possibile pertanto descrivere l’attuale grado in cui versa la crisi sistemica anche quale conflitto generalizzato tra capitali in incessante (e crescente) competizione per superare le difficoltà di valorizzazione date dall’eccesso diaccumulazione e in conflitto per l’accaparramento di risorse, profitti (da economia “reale” eproduttiva) e rendita finanziaria.
L’IRRAZIONALITA’ DEL MODO DI PRODUZIONE CAPITALISTICO
E’ noto che la ciclicità del verificarsi di crisi, generate dal movimento e dalle intime contraddizioni del modo e degli attuali rapporti sociali di produzione, rappresenti anche l’occasione per un rinnovamento sistemico (attraverso la modifica delle forme – ma non del modo – della produzione stessa, nonché degli ambiti di valorizzazione dei capitali) che permettano la definizione di nuovi equilibri più avanzatiche permettano una tenue stabilità (sebbene, nel medio-lungo periodo, non possono che rivelarsi altrettanto provvisori e precari).Certo è che l’attuale crisi (strutturale), per l’elevato grado di maturazione raggiunto, evidenzia tutta l’irrazionalità di un sistema in cui i rapporti sociali di produzione datirappresentano il concreto ostacolo per un ulteriore sviluppo del livello raggiunto dalle forzeproduttive e in cui la ricchezza sociale prodotta è concentrata nelle mani di un numero sempre più esiguo di soggetti. Ciò a maggior ragione ove si osservi che le crescenti difficoltà per il capitale complessivo divalorizzarsi, nonché di adeguare la propria struttura per la ricerca della massimizzazione delprofitto, è oggi aggravata dall’inefficacia di tutte quelle misure economiche e sociali che nel corso del tempo hanno rappresentato, anche solo parzialmente, un freno alla progressiva stagnazione e alla inesorabile caduta del tasso di profitto complessivo.
La logica conseguenza diquesta inadeguatezza – e diverse evidenze già vi sono a dimostrarlo – è lo scaricarsi sulla situazione di estrema confusione e indeterminatezza dello scontro intercapitalistico in atto e della conseguente accelerazione della tendenza al conflitto in ogni forma, anche bellica, e alla distruzione (anch’essa, comunque intime e intrinseche al modo di produzione capitalistico: capitalismo e guerra non possono che alimentarsivicendevolmente).
La profonda spinta data dal progresso tecnologico e dalla robotizzazione che hanno permesso di razionalizzare la produzione, di ridurne i costi e di velocizzare la circolazione aumentando però, di converso e inesorabilmente, la composizione organica del capitale (il progressivo incremento della sua parte costante – macchine, tecnologie, automazione – a spese del capitale variabile – la forza lavoro -) e la progressiva caduta del saggio di profitto; il ricorso alla finanza speculativa e alla pletora degli strumenti creati per permettere di “scommettere” sui mercati finanziari e ottenere profitti compensando le perdite e/o i rallentamenti della produzione reale che però è stata foriera della creazione di bolle e della loro esplosione; la compressione salariale e l’intensificazione del grado di sfruttamento del lavoro che ha determinato forme parossistiche di nuove schiavitù e di modalità di sfruttamento della forza lavoro che ha creato diseguaglianze inedite e sempre più profonde; l’espansione dei mercati mondiali sino alla loro saturazione e l’aumentata competizione per risorse finite e per il controllo della logistica internazionale; le politiche di austerity che hanno sterilizzato il consumo e la spesa pubblica, appaiono oggi la cartina di tornasole che ci restituisce l’immagine plastica di un sistema il cui destino ineluttabile è ben diverso dalla sua autorappresentazione anche ideologica: e cioè l’assenza di limiti reali alla ricchezza e allo sviluppo inarrestabile dei rapporti di produzione sottesi.
Le dichiarazioni delle classi dirigenti delle potenze mondiali che seguono quelle delle rispettive borghesie nazionali, le risposte che stanno pianificando, rendono evidente la loro consapevolezza circa gli strumenti da utilizzare per rilanciare una nuova accumulazione nel tentativo di superare le difficoltà predette. E questi non possono che tradursi in ulteriori misure di attacco al lavoro e alle masse popolari, nel continuo drenaggio di risorse in favore dei profitti, nella compressione della spesa pubblica (anche per favorire l’espansione dei processi di privatizzazione dei servizi e dei diritti sociali sino a oggi considerati universali) e allo sgretolamento delle residue tutele, in quella complessiva lotta di classe che da anni il padronato sta conducendo nei confronti del proletariato.
E’ infatti ormai evidente, come anticipato, che l’implementazione alla produzione data dalla robotizzazione, dalla automazione e dalla prima informatizzazione abbia comportato nel lungo periodo una sovra-accumulazione di capitali a livello mondiale e il correlato eccesso di capacità produttiva (e del suo concreto pieno utilizzo alle condizioni date di domanda). Il progressivo investimento in capitale costante (macchinari, infrastrutture, software, ecc.), favorito dall’inaudito ed esponenziale sviluppo tecnologico, ha disegnato nuove forme di modalità di produzione nel quale il capitale variabile è arrivato ad essere considerato superfluo o comunque ridimensionato nei numeri e nell’apporto, ma che determina il progressivo aumento della composizione organica con inevitabile riduzione del saggio dei profitti realizzabili.



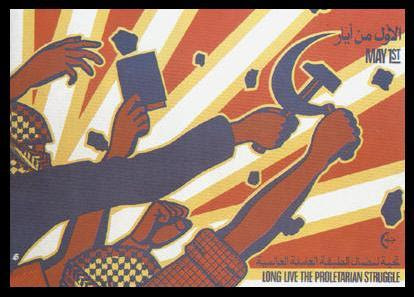
Commento all'articolo