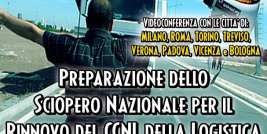Riceviamo e pubblichiamo dai compagni del Cuneo Rosso queste note di aggiornamento sulla crisi economica, che sono un supplemento al documento "Il temuto 'cigno nero' (una nuova crisi) è arrivato" che trovate di seguito.
Note di aggiornamento sulla crisi economica
Dalla stesura del testo Il temuto “cigno nero” (una nuova crisi) è arrivato. Che sia il canto del cigno del capitalismo decadente!, che abbiamo pubblicato il 13 marzo, la situazione è andata peggiorando a grandi passi, fino a sfiorare scenari catastrofici. I dati economici, le dichiarazioni dei personaggi chiave e le decisioni dei più importanti centri di governo dell’economia mondiale si susseguono a ritmo incalzante.
La situazione è in costante evoluzione e si fatica a seguirne gli sviluppi. Dopo i crolli record di tutte le Borse mondiali, di cui si dà conto nelle note che seguono, Wall Street e le altre piazze finanziarie internazionali hanno fatto registrare aumenti record, che travalicano i rimbalzi tecnici legati ai riacquisti di titoli per monetizzare i capital gains guadagnati con le vendite allo scoperto, e testimoniano innanzitutto di una estrema volatilità dei mercati borsistici che, con ogni probabilità, si protrarrà a lungo.
Si fanno quindi sentire le conseguenze delle manovre monetarie assolutamente eccezionali messe in campo dalla FED, dalla BCE e dalle altre Banche Centrali e gli imponenti stanziamenti di bilancio che tutti gli Stati imperialistici stanno preparando. Non c’è dubbio che l’insieme di questi interventi sarà finalizzato al sostegno del sistema (banche e grandi imprese, in primis), costi quello che costi. Ma i capitalisti di tutti i paesi già si interrogano sul che fare e con quali strumenti affrontare la crisi, quando sarà forse sotto controllo l’epidemia di covid-19 ma infurierà quella economica, la disoccupazione di massa, i probabili rincari dei generi di prima necessità, ecc. Non possiamo prevedere la strada specifica che ciascuno Stato percorrerà, ma è certo che la classe lavoratrice tutta dovrà fronteggiare un’offensiva di inusitata violenza, in cui la crescita del nazionalismo e gli appelli all’unità “di tutto il popolo” assumeranno sempre più minacciosamente i caratteri di un ultimatum verso le masse affinché si prostrino davanti alle rapaci esigenze capitalistiche, mentre le avanguardie di classe verranno additate come “nemici della patria” da perseguire e disperdere. Ed è inoltre probabile che tale offensiva sarà accompagnata, in qualche misura, da misure demagogiche, di cui si scorge già qualche elemento, che non toccheranno affatto gli interessi di fondo del grande capitale e la sua ferrea determinazione a scaricare i costi della crisi sulle spalle degli sfruttati, ma serviranno a gettare fumo negli occhi per spacciare la tesi che “tutti dobbiamo partecipare al risanamento economico”. Un risanamento che costerà al proletariato lacrime e sangue in misura incomparabilmente maggiore di quanto sia già avvenuto e ai ceti dominanti, magari, qualche irrilevante spicciolo a testimonianza del loro spirito caritatevole.
Ricordiamo infine che le note seguenti, da leggere come un aggiornamento del documento che citiamo all’inizio, sono state chiuse domenica 22 marzo.
***
Ancora giovedì 12, in conferenza stampa, Christine Lagarde, annunciando un più consistente intervento della BCE, parla di “ridimensionamento delle prospettive di crescita europee”, un linguaggio felpato che mal si sposa con il contesto drammatico della situazione. E’ lì che pronuncia l’ormai celebre battuta sugli spreads dei paesi più deboli, che fa crollare le Borse del vecchio continente, spingendo Piazza Affari al record storico di -16,92%, dopo che appena il 9 marzo aveva chiuso a -11,7%. Come termine di paragone, si può considerare che nel 2011, cioè nel pieno della crisi del debito sovrano, la Borsa italiana arrivò a perdere, in 4 mesi, il 40% dell’indice, oggi si è quasi raggiunto questo livello di crollo delle quotazioni nello spazio di un solo mese a far data dal 21 febbraio e su base settimanale, con un -23%, è stato già superato il record negativo del -21% registrato nella crisi del 2008. Ovviamente, sull’andamento delle Borse pesano tutti i fattori negativi che si accumulano e si aggravano vicendevolmente, dai rischi crescenti di default a catena delle aziende, alle ripercussioni di questi sul sistema bancario, alla prosecuzione della “guerra del petrolio” fra Riad e Mosca, e sui quali la dichiarazione di “disinteresse” della BCE sull’andamento degli spreads dell’area euro non può che avere un effetto moltiplicatore.
I mercati finanziari USA
Sui mercati finanziari USA il caos è andato avanti per tutta la settimana appena trascorsa, facendo registrare almeno due elementi ulteriori. Il primo di questi è l’inversione di tendenza del mercato dei Treasury Bonds, che da “bene rifugio”, nei primi giorni della crisi, ha virato verso le vendite massicce, come testimonia la crescita dei rendimenti (ricordiamo che la quotazione dei titoli, cioè il prezzo a cui vengono comprati e venduti in Borsa, è inversamente proporzionale al rendimento degli stessi). Si tratta di un fenomeno preoccupante, per la stabilità dell’economia capitalistica. Il mercato dei titoli di Stato americani, infatti, è immenso e rappresenta da sempre un porto sicuro per parcheggiare i capitali in attesa di tempi migliori. E’ la rappresentazione stessa del concetto di “mercato liquido”, cioè di un mercato in cui ogni investitore può entrare e uscire senza difficoltà, cioè senza che il prezzo di vendita o di acquisto, che è il parametro fondamentale su cui si basano le decisioni dei capitalisti, subisca variazioni significative. Ciò permette ai possessori di capitale monetario di fare previsioni, ragionevolmente sicuri che le proprie decisioni di vendita o di acquisto non incideranno sui prezzi correnti, stante la dimensione enorme di quel mercato, che può assorbire movimenti anche molto ampi senza che si squilibri il rapporto fra domanda e offerta. Ecco perché i titoli di Stato USA rappresentano un bene rifugio per eccellenza.
La progressiva perdita della sua liquidità, per l’alluvione di vendite, ha suonato dunque il campanello d’allarme per la FED, che ha scorto in questo fenomeno l’indizio, oltreché del panico dilagante, della forsennata ricerca di denaro contante per fronteggiare i crescenti rischi di fallimento.
Il secondo elemento di rilievo è stato l’aggravarsi della situazione sul mercato interbancario, un fenomeno già presente mesi prima che il covid-19 facesse la sua comparsa, ma che dall’epidemia è stato esasperato ulteriormente. Si tratta di uno snodo finanziario fondamentale, il cui blocco ha avuto un peso molto forte nel propagarsi della crisi del 2007-2008 e che, per le interconnessioni globali dei mercarti finanziari, non si limita allo scenario USA ma investe tutto il pianeta. Il sommarsi di questi due fattori di rischio ha spinto la FED ad un intervento pesantissimo su entrambi i fronti che, nel caso del mercato interbancario, ha mobilizzato, in coordinamento con le altre principali banche centrali, circa 1500 miliardi di dollari.
L’intervento della FED
Prima di tornare allo scenario europeo, è opportuno qualche altro accenno a quanto avvenuto su quello americano. La FED ha finalmente ottemperato ai desiderata dell’amministrazione Trump portando a zero i tassi d’interesse e annunciando massicci acquisti di titoli. Nonostante ciò, Wall Street è letteralmente sprofondata, col Dow Jones a -13% (superiore al record negativo del 1987) e il Nasdaq (titoli tecnologici) a -12% e una perdita cumulata che annulla la spettacolare crescita registrata nell’ultimo anno. La caduta degli indici, dopo l’annuncio di Powell di una politica monetaria quanto mai espansiva, ha fatto parlare molti analisti di un crollo di Borsa avvenuto non nonostante gli interventi di sostegno della FED (che sarebbe già grave), ma a causa di questi (che dal punto di vista dell’economia politica borghese è un arcano inspiegabile). La lettura possibile è che i provvedimenti sono stati letti da finanzieri, banche, hedge.funds, ecc. come spia della gravità della situazione, una mossa disperata cui si è risposto con la fuga pura e semplice dai mercati finanziari. La FED ha poi rilanciato un altro strumento eccezionale già usato nel 2008 che è l’acquisto di commercial papers, cioè di quei titoli di credito/debito (cambiali, tratte, ecc.) che le aziende sottoscrivono l’una con l’altra e che poi “scontano” in banca per monetizzarle immediatamente e assicurarsi i flussi di cassa necessari senza aspettare la scadenza naturale. E’ un’operazione di competenza delle normali banche commerciali e il fatto che la Banca Centrale se ne faccia carico direttamente, sostituendosi agli istituti di credito, è un altro indice della gravità della situazione, perché significa che la crisi delle aziende ne mette a rischio l’esistenza, minando alla radice il credito commerciale usuale e quindi la possibilità di scontarlo presso le Banche Commerciali. Queste, a loro volta, sono sempre più restie ad accollarsi rischi aggiuntivi in un mercato sottoposto ad una violenta contrazione, tenuto conto che hanno già accumulato perdite che potrebbero metterne in discussione la stabilità. Inoltre, la FED ha provveduto a stipulare accordi cosiddetti swap con la BCE e altre Banche Centrali per assicurare la fornitura adeguata di dollari alle imprese di tutto il mondo che hanno impegni in valuta americana e prevenire turbolenze nel mercato dei cambi, una necessità tanto maggiore quanto più il biglietto verde continua ad essere, nonostante il declino relativo della supremazia yankee sul mondo, la moneta di riferimento per gli scambi commerciali, le transazioni finanziarie e gli accantonamenti delle riserve valutarie.
Oltre alle misure della FED, il governo USA proporrà al Congresso lo stanziamento di una cifra compresa fra i 1000 e i 1500 miliardi di dollari per aiuti alle imprese colpite, in testa a tutte quelle legate al trasporto aereo (la Boeing ha già presentato una richiesta di 60 miliardi di dollari) e, in parte, anche ai lavoratori, sia con assegni una tantum, sia prevedendo una qualche forma di pagamento del salario in caso di malattia, dal momento che oltre un terzo dei salariati USA non gode di questo diritto. Certamente, altri provvedimenti dovranno essere presi, se molte “autorevoli” previsioni parlano di un tasso di disoccupazione destinato a schizzare dall’attuale 3,5% (per quanto calcolato con metodi statistici mirati a gonfiare il livello di occupazione reale) al 20%, nel quadro di una recessione che tutti danno per certa.
Il quadro europeo
Tornando allo scenario europeo, l’Italia si conferma il cuore dell’epidemia sanitaria e uno dei paesi in cui gli effetti della crisi si faranno sentire più pesantemente. Una prima stima del Cerved parla, a seconda della durata dell’epidemia, di un crollo del PIL di circa 640 miliardi di euro in due anni, con un rischio fallimento per il 10% delle imprese. Le ultime dichiarazioni della Confindustria, che non si ritiene ancora soddisfatta, nonostante abbia fatto inserire nel Decreto di Conte sulla chiusura delle produzioni non essenziali molte imprese cosiddette strategiche (compresa la produzione degli F35 a Cameri!), parlano comunque di una perdita quantificabile in 150 miliardi € al mese. Non va molto meglio negli altri paesi del vecchio continente. Il progressivo blocco di rilevanti settori economici, infatti, è generale e, con sfasature temporali dovute alla diversa fenomenologia epidemica, coinvolge tutti. Certo, non ci sono dubbi che si farà sentire la forza differente di cui è dotata ad esempio la Germania rispetto all’Italia, ma si tratterà comunque di una “discesa agli inferi” che non risparmierà nessuno. Per adesso, le misure di bilancio messe in cantiere dai principali Stati parlano di cifre che, per la Germania, sono già lievitate dagli iniziali 550 miliardi agli 800 e passa, mentre in Francia si parla di un impegno di 300/400 miliardi. Per tutti, si ragiona intorno a stanziamenti di molti punti del PIL, ma è ancora presto per i dettagli.
A ciò va aggiunto, per tutti i paesi, la progressiva riduzione del credito bancario come conseguenza della lievitazione dei crediti deteriorati, cioè di difficile o impossibile riscossione, che, per l’Italia, si stima aumenteranno di 40 miliardi in due anni. Già ora la massa di questi crediti deteriorati è ingente e ciò ha comportato per la maggior parte delle banche italiane un calo di redditività, nonostante le condizioni di estremo favore a cui hanno potuto rifornirsi di denaro presso la BCE. Un ulteriore elemento di rischio in Europa è costituito dalle cosiddette “cartolarizzazioni”. Si tratta di operazioni attraverso le quali gli istituti di credito convertono i mutui casa in “prodotti finanziari” che poi vendono, sotto forma di “obbligazioni garantite”, dando vita ad un castello di derivati che, non a caso, è stato il detonatore della crisi dei mutui subprime. Il fatto che agenzie di rating come S&P si siano affrettate a minimizzare i rischi connessi a questo segmento del mercato è tutt’altro che tranquillizzante. Basti ricordare che tredici anni fa, come adesso, le dichiarazioni “europee” circoscrivevano il fenomeno al mercato immobiliare americano, dichiarando il vecchio continente estraneo al rischio ed esaltando per l’Italia, più ancora che per gli altri paesi, l’àncora di salvezza costituita dalla solidità finanziaria delle famiglie e dal loro basso livello di indebitamento, certo inferiore a quello americano. Al centro di questo groviglio stanno gli istituti di credito ufficiali e il sistema bancario ombra, che specula costantemente sul mercato dei derivati, la cui caratteristica è quella di dar vita ad una massa di debiti potenziali impossibili da calcolare ma, proprio per questo, dall’enorme capacità distruttiva . E se il problema prevalente per le banche italiane è connesso alla fluttuazione del valore dei titoli di stato, di cui i loro portafogli sono pieni, per le banche francesi e tedesche il rischio derivati sembra essere quello peggiore. Questo contribuisce a spiegare perché, nel generale bagno di sangue delle Borse, i titoli bancari sono fra quelli che hanno perso di più, particolarmente a Piazza Affari.
L’intervento della BCE
Abbiamo detto prima che, in occasione della conferenza stampa in cui Lagarde è inciampata sugli spreads, rivelando l’esistenza di contrasti di interesse fra gli Stati azionisti della BCE, è stato presentato il piano di intervento di Francoforte. Vediamone allora in sintesi le linee guida.
Ad onta degli innegabili contrasti, sembra che non vi siano dubbi nel Consiglio Direttivo su come agire nell’immediato per fronteggiare una crisi che si preannuncia molto più profonda di quella del 2007-2008. Lo scontro fra i fratelli-coltelli della moneta unica non è certo risolto, ma riguarda le prossime mosse, non la terapia d’attacco da mettere in campo.
Scivoloni a parte, il piano presentato in conferenza stampa è in linea con l’ormai celeberrimo “whatever it takes” di Draghi. E’ un piano che, sulla scorta dell’esperienza degli ultimi anni, si muove lungo tre direttrici:
Immissione di liquidità
Azione sui tassi d’interesse e sulle operazioni di rifinanziamento
Interventi sulla vigilanza bancaria
1 – L’immissione di liquidità. Parliamo di un piano di acquisto di titoli pubblici e privati (cioè obbligazioni di società quotate in Borsa) per un ammontare di almeno 750 miliardi €, cui si aggiungono sia i 120 miliardi deliberati il 12 marzo che la continuazione del piano di acquisti di 20 miliardi al mese. Lagarde ha detto esplicitamente che gli acquisti saranno fatti con tutta la flessibilità necessaria riguardo ai paesi emittenti, alle classi di titoli, alle singole emissioni, ecc. Perché è importante questa sottolineatura sulle modalità di acquisto dei titoli, che sembra solo un particolare di contorno ispirato al semplice buon senso? Perché è questa flessibilità che permette alla BCE di aggirare ancora una volta i vincoli statutari e di muoversi quasi come la Banca Centrale di uno stato unitario e non come un organismo di governo della moneta unica nel quadro di una pluralità di Stati per i quali funziona da stanza di compensazione. Spieghiamoci meglio.
La Banca Centrale Europea non può, per statuto, monetizzare il debito pubblico degli Stati dell’area euro e quindi non può partecipare alle aste nelle quali il Tesoro dei vari paesi colloca sul mercato i relativi titoli. Non si tratta però di una norma “voluta dalla Germania”, perché tale norma è stata introdotta in Italia nel 1981, vent’anni prima dell’euro, col famoso divorzio fra Tesoro e Bankitalia. Prima di allora, il Tesoro godeva di un conto corrente presso la Banca Centrale da cui poteva attingere e, quando emetteva BOT, CCT, BTP, ecc., cioè chiedeva soldi in prestito, lo faceva con la garanzia di Bankitalia di sottoscrivere “l’inoptato”, cioè l’istituto di emissione si impegnava a comprare quella parte del debito pubblico che non aveva trovato acquirenti, ovviamente stampando moneta. Subentrato il cosiddetto divorzio, questa garanzia è caduta e il Tesoro da allora non può contare sul paracadute della Banca Centrale, ma deve provvedere da sé a collocare sui mercati finanziari tutto il debito che gli serve, pagando tassi di interesse maggiori, se questo serve a renderlo più appetibile. Bankitalia, a sua volta, non è più costretta a stampare moneta per sostenere la spesa pubblica, ma regola la quantità di circolante sulla base delle proprie autonome valutazioni in quanto ente cui è demandato il compito di assicurare “il buon andamento dell’economia” ovviamente dal punto di vista degli interessi complessivi del capitalismo. E’ vero che, storicamente, chi incarna questa impostazione è la Bundesbank, ma, appunto, tali vincoli erano già presenti prima della moneta unica.
Tornando alla BCE, l’azione di acquisto dei titoli avviene dunque sul mercato secondario, cioè in Borsa, ma questo modus operandi è solo un meccanismo per aggirare i vincoli esistenti, dal momento che acquisti massicci come quelli deliberati non possono essere fatti senza stampare moneta. La differenza, però, è che, agendo sul mercato secondario, la BCE non può impedire che certi fenomeni prendano corpo, può solo intervenire post festum, rincorrendo, per così dire, gli avvenimenti. Ma nel piano annunciato da Lagarde, col corollario della flessibilità, c’è soprattutto l’escamotage per cancellare di fatto, anche se non formalmente, la differenza fra il Quantitative Easing (QE) e le Outright Monetary Transactions (OMT). Il QE, infatti, è sì l’acquisto di titoli in Borsa, ma lo schema in base al quale la BCE lo esegue prevede acquisti proporzionali alla quota con la quale i diversi Stati partecipano al capitale della BCE stessa, in modo tale da rispettarne la funzione, che dev’essere generale, finalizzata a dare liquidità all’economia, senza avvantaggiare nessuno Stato in particolare. Le OMT, invece, sono operazioni della BCE volte a sostenere i titoli di un determinato paese, per contenere la crescita dello spread – cioè il differenziale di rendimento – fra i titoli di quello stesso paese e quelli corrispondenti di un paese preso a pietra di paragone che, in Europa, sono i bund tedeschi. Le OMT, però, presuppongono che uno Stato chieda l’intervento del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità – il vecchio fondo salva-Stati), il quale provvede ad attivare le ECCL, cioè le linee di credito rafforzate, destinate a quei paesi, come l’Italia, non in regola coi parametri europei, linee di credito a loro volta concesse sulla base della firma di un memorandum, le cosiddette “condizionalità”. In pratica, ciò significa che lo Stato che chiede l’intervento del MES si sottopone ad un piano di aggiustamento di bilancio, contrattato con i partners europei. A questo punto, esperita tutta questa trafila, possono attivarsi le OMT, che sono il corrispondente monetario delle operazioni di bilancio del MES. Il piano annunciato dalla BCE, però, prevede appunto tutta la flessibilità richiesta dalla situazione e, pur nel rispetto formale delle regole, consente a Francoforte di trasformare in modo duttile il QE in OMT. Si potrà infatti derogare alla proporzionalità degli acquisti di titoli in base alla partecipazione al capitale BCE, le operazioni in Borsa riguarderanno tutte le curve di rendimento, tutte le classi di attività e si potrà infrangere, sempre in nome della flessibilità, il tetto del 33% di ciascuna emissione, che prima non si poteva superare e tutto ciò finché la situazione lo richiederà (cioè oltrepassando il limite dei 750 miliardi). Per fare questo, la governatrice Lagarde ha affermato che le turbolenze del mercato dei titoli mettono a rischio la stabilità dei prezzi e ostacolano la trasmissione omogenea della politica monetaria a tutti i paesi, un’enfatizzazione che ha il solo scopo di ancorare il comportamento della BCE alla sua mission statutaria, proprio nel momento in cui, per cause di forza maggiore - accettate obtorto collo da tutti gli Stati - essa è costretta a discostarsene. E in omaggio alla regole, la Lagarde ha ribadito, nel gergo oscuro dei tecnocrati, che “il benchmark per la ripartizione degli acquisti continuerà ad essere lo schema di partecipazione delle banche centrali nazionali al capitale della BCE, ma gli acquisti saranno fatti in modo flessibile”. Come dire: la regola è sempre quella, ma ci muoviamo nel territorio dell’eccezione…
Inoltre, è stato deciso l’acquisto di commercial papers, come ha fatto la FED e con il medesimo obiettivo di sostenere il credito commerciale messo a rischio dalla crisi, evitando che si ripercuota negativamente sulle banche ordinarie.
Vale la pena di aggiungere, prima di trattare gli altri due campi di intervento della BCE, che le caratteristiche appena illustrate del piano di QE/OMT rendono meno pressante la questione dell’utilizzo del MES o, quanto meno, cambiano i termini del problema. A questo punto infatti il MES non serve per attivare le politiche monetarie straordinarie della Banca Centrale, che vedono la luce indipendentemente da esso. Il dibattito sul MES si incentra così sulla possibilità che esso diventi l’ente emittente (altri candidati sarebbero la Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti) degli Eurobonds nella forma dei coronavirusbond, titoli di debito europei, finalizzati a sostenere i costi diretti e indiretti della pandemia, meccanismo che eliminerebbe alla radice ogni discorso sulla sottoscrizione di “condizionalità” più o meno attenuate, facendo venir meno il rischio per uno Stato di dover sottoporre il proprio bilancio all’approvazione preventiva di una troika, qualunque nome questo organismo possa assumere. Il MES, pare di capire, emetterebbe i titoli e li collocherebbe sul mercato, ad un tasso di interesse probabilmente basso, vista la garanzia dell’intera Unione Europea, e ripartirebbe i fondi fra gli Stati partecipanti, oppure gli stessi eurobond sarebbero collocati sul mercato dalle varie Banche Centrali nazionali secondo una proporzione prestabilita (mantenendo ovviamente la natura di titoli di debito dell’Unione nel suo insieme). Ogni Stato, comunque, dovrebbe impegnarsi a utilizzarli per le finalità per cui sono nati e non per alimentare arbitrariamente la propria spesa pubblica. Sostenitrici di tale linea sono Italia e Francia, col probabile concorso di altri paesi mediterranei, ma da Germania, Austria, Olanda, ecc. c’è stata immediatamente una levata di scudi, per la nota ostilità a condividere il rischio sovrano con i paesi ad alto debito. Il varo di questo strumento, che nella frenesia degli interventi anticrisi sembrava ormai imminente, torna dunque in alto mare.
2 – L’intervento sui tassi di interesse e le operazioni di rifinanziamento. La possibilità di ridurre i tassi d’interesse in Europa è estremamente ridotta, essendo questi ormai a zero per i depositi delle banche nazionali presso la Banca Centrale e già negativi per le normali operazioni di rifinanziamento (cioè per i capitali che gli istituti di credito chiedono a Francoforte per impegnarli a loro volta nei prestiti alla clientela). La BCE ha deciso di destinare 3000 miliardi € ad una nuova operazione di rifinanziamento denominata TLTRO3, per distinguerla dalle due precedenti. Il tasso di interesse applicato potrà arrivare al -0,75%. Che cosa significa tutto ciò? Innanzitutto, occorre chiarire che le cosiddette TLTRO (una sigla che sta per targeted longer-term refinancing operations) sono operazioni con le quali la BCE concede prestiti a lunga scadenza alle diverse banche nazionali, con l’obbligo per le banche stesse di prestare tali capitali a imprese non finanziarie o alle famiglie, con l’esclusione dei mutui immobiliari. Si tratta di uno strumento per incentivare la concessione di prestiti alla cosiddetta “economia reale” e il cui tasso d’interesse diviene progressivamente conveniente per gli istituti di credito quanto più la quantità di questi prestiti cresce rispetto alla media dei prestiti dello stesso tipo che essi hanno concesso nel periodo precedente il rifinanziamento. In questo caso, Lagarde ha dichiarato che il tasso di interesse potrà arrivare fino a -0,75%, “per amplificare lo stimolo costituito dai tassi negativi”. In altre parole, la BCE mette a disposizione delle banche dei vari paesi europei 3000 miliardi € e le banche che li prenderanno a prestito non solo non pagheranno interessi, ma riceveranno dalla Banca Centrale un premio crescente col crescere del denaro preso a prestito. Contemporaneamente, Francoforte ha deciso di ampliare la gamma dei titoli che saranno accettati come collaterale (cioè come garanzia) dei prestiti: in pratica, le banche potranno dare in garanzia non solo titoli di stato ma anche altri titoli molto meno sicuri (non si è parlato di obbligazioni spazzatura ma ci siamo vicini) ed è stato esteso il numero degli intermediari finanziari che potranno accedere alle TLTRO (fondi vari e altri soggetti meno istituzionali), che dà il senso dello sforzo che si cerca di sostenere per fare arrivare ossigeno all’economia.
3 – Interventi di vigilanza bancaria. Con questi interventi, la BCE ha liberato circa 120 miliardi € di capitale bancario, rendendoli disponibili per l’utilizzo. In che cosa consistono questi provvedimenti? Consistono nell’allentamento delle cosiddette regole di Basilea, cioè di quell’insieme di norme che stabiliscono la quantità degli accantonamenti che le banche sono obbligate a detenere, i ratios di capitale e patrimonio ecc., cioè il rapporto fra mezzi propri e impieghi, che assicura la solidità di un istituto di credito e la sua capacità di far fronte alle diverse congiunture senza metterne a rischio l’attività. Allentando questi vincoli, si permette alle banche di avere una minor quantità di capitale inattivo (tenuto come garanzia) e di ampliare quindi i propri impieghi. Ovviamente, è una misura che va nella stessa direzione delle precedenti, quella di liberare risorse finanziarie da iniettare nell’economia capitalistica e che è stata da più parti salutata come il primo tentativo di dare alle norme di Basilea una funzione anticiclica, anziché prociclica, in altre parole, di agevolare il superamento delle difficoltà invece di aggravarle.
Ma anche in questo campo, come in quelli che abbiamo esaminato sopra, non si può non notare che il sistema capitalistico affronta le proprie crisi “preparando crisi più estese e più violente e riducendo i mezzi per prevenire le crisi”, come si esprimeva il Manifesto del Partito Comunista circa centosettant’anni fa. Nello specifico, ridurre gli accantonamenti prudenziali delle banche e abbassare il rapporto fra mezzi propri e impieghi aumenta la fragilità del sistema creditizio ed espone l’economia a rischi ancora più elevati. Alcuni analisti hanno calcolato che la modifica delle norme di Basilea nella direzione preannunciata da Lagarde consentirà alle banche di moltiplicare per 5 la massa di crediti deteriorati di cui potranno caricarsi e, insieme a questi, crescerà esponenzialmente il rischio di insolvenza generalizzato.
Qualche considerazione finale
Le linee di intervento della BCE e della FED danno conto dell’enorme preoccupazione che esiste nei circoli dominanti del vecchio continente e del mondo intero per una crisi che si annuncia di sconvolgente profondità. Accreditati e prudenti istituti internazionali parlano, per fare solo un esempio, di un crollo del PIL tedesco dell’ordine del 20% (!) con milioni di disoccupati, una situazione ancora peggiore per paesi come l’Italia che sono entrati in questa emergenza in condizioni certo peggiori di Berlino e un “rischio” crescente e generalizzato di rivolte sociali.
Per l’Europa, esiste la possibilità concreta che questa crisi, aumentando ulteriormente la divaricazione fra i diversi paesi, suoni la campana a morto dell’euro e della stessa Unione. Si tratterebbe di uno scenario di gigantesca destabilizzazione non solo dei rapporti economici ma dello stesso status quo internazionale. Allo stesso tempo, si conferma che anche sul terreno monetario e finanziario le classi dominanti cercano di neutralizzare gli effetti della crisi rafforzando contraddittoriamente gli elementi di sistema che ne facilitano le esplosioni, a partire dalla finanziarizzazione e dall’impiego massiccio di droga monetaria per sostenere l’intera baracca. Anche sull’efficacia immediata di queste misure c’è più di un punto interrogativo. Per fare un ulteriore esempio, l’abbassamento del tasso di interesse a -0,75% (sarebbe più corretto dire “l’innalzamento del tasso negativo di interesse”) per le TLTRO non è detto che spingerà le banche ad utilizzarli, così come l’allentamento delle regole sui coefficienti di stabilità degli istituti di credito. Come già avvenuto in passato, è possibile che le banche preferiscano continuare a rifinanziarsi con le LTRO (meccanismi di rifinanziamento che non hanno i vincoli delle TLTRO, anche se hanno un tasso intorno allo zero), magari per diversificare i propri portafogli titoli o intervenire speculativamente sui derivati, piuttosto che finanziare imprese traballanti, col rischio di esporsi a rischi maggiori. La stessa Lagarde, infatti, ha affermato che le decisioni della BCE devono essere affiancate da adeguate misure di bilancio, capaci di fornire ulteriori garanzie, ad es. per le piccole e medie imprese, sulla loro capacità di far fronte agli oneri finanziari, ecc.
Sta di fatto che la crisi economica esaspera le diverse velocità a cui girano gli Stati dell’Unione Europea. Quanto reggerà l’euro, in un contesto mondiale che quasi tutti non esitano a definire di recessione generalizzata, di economia di guerra, di acuto scontro commerciale, di conflitto fra USA e Cina ecc.?
Un economista un po' critico come Roubini, in un intervista di alcuni giorni fa a Repubblica, ha sostenuto che l’attuale è la peggiore crisi della storia, peggiore di quella del 2008 e forse più grave anche della Grande Depressione del 1929 e che è giunto il momento dell’helicopter money, cioè di fornire denaro direttamente ai cittadini per tamponare le conseguenze della crisi. Per farlo, ipotizza un intervento che necessita di una legge che sospenda provvisoriamente, paese per paese, il divorzio fra Banca Centrale e Tesoro e che vedrà al suo termine una crescita rilevante dell’indebitamento pubblico (anche di 20 punti o più). Per il futuro, dice Roubini, “si studieranno metodologie di rientro del deficit”. E’ una strategia che in qualche modo si sta già facendo strada nell’establishment europeo, anche se, con ogni probabilità, non si arriverà alla legge di cui parla Roubini, ma si preferirà continuare ad aggirare le regole della governance europea nella speranza di ritrovarle intatte quando la bufera sarà passata. Del resto, la sospensione a tempo indeterminato del Patto di Stabilità (e, in piccolo, la decisione della Commissione Europea che consente all’Italia l’utilizzo degli 11 miliardi € di fondi non utilizzati) approvata ieri dall’Ecofin serve appunto a sbloccare le politiche di bilancio degli Stati.
Fare più deficit è una strada, la principale oggi, che le classi dominanti europee pensano di imboccare per fronteggiare la crisi in corso, nella consapevolezza che il peso del maggior debito ricade comunque sulle spalle dei proletari. Il pragmatismo prevalente nei circoli di potere forse fa ritenere l’attuale emergenza una condizione transitoria, trascorsa la quale sarà possibile un rafforzato mix di autoritarismo sociale e politico (magari giustificato da un’epidemia sotto controllo ma non completamente debellata) e un rilancio in grande stile del nazionalismo per avviare un’altra stagione di sacrifici e di macelleria sociale ancora più intensa. Ma non si può escludere che la profondità della crisi, il carattere devastante delle sue conseguenze sugli sfruttati, la crescita degli antagonismi all’interno dell’UE conducano allo sconquasso della moneta unica e alla sperimentazione di altri metodi per scaricare sui lavoratori i costi della crisi. Le classi dominanti italiane e di altri paesi potrebbero essere spinte ad una riedizione del film già visto negli anni ’70, un’inflazione a due cifre, con l’indubbio vantaggio di un proletariato disorganizzato da decenni di sconfitte e compromessi e l’assenza di ogni strumento capace di far recuperare ai salariati la perdita del loro potere d’acquisto. Di certo, qualunque strada imboccherà la crisi attuale e quali che siano le soluzioni verso cui la classe capitalistica si orienterà, l’alternativa fra un inasprimento enorme della miseria e dello sfruttamento, nella prospettiva di una crescita dei conflitti interimperialistici sullo scacchiere mondiale, e la riorganizzazione politica dei ranghi proletari per contrastare le classi dominanti si porrà in modo sempre più stringente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il temuto “cigno nero” (una nuova crisi) è arrivato.
Che sia il canto del cigno del capitalismo decadente!
Sotto la sferza dell’epidemia di coronavirus, una nuova crisi produttiva e finanziaria del sistema capitalistico internazionale è tornata a farsi estremamente vicina e, mai termine fu più appropriato, virulenta.
Se a dar fuoco alle polveri nel 2007/2008 sono stati i mutui sub-prime, oggi è il covid-19 ad aprire le danze, cioè uno shock esogeno, anche se tale aggettivo è corretto solo se utilizzato in senso stretto, cioè prescindendo da tutte le devastazioni che il modo di produzione capitalistico ha inferto all’ambiente naturale, nel senso più ampio del termine e che, negli ultimi decenni, si sono estese e approfondite con una progressione esponenziale.
In ogni caso, il coronavirus ha svolto la funzione di detonatore di contraddizioni e problemi che l’economia capitalistica porta in grembo da tempo e che, a dispetto del suo andamento ciclico – fatto di recessioni/crisi finanziarie e riprese successive e nonostante la situazione diversa in cui si collocano le differenti aree – si caratterizza per una difficoltà crescente della riproduzione capitalistica a scala globale, che ha la sua radice nella crescente difficoltà di valorizzazione, della quale i più sofisticati artifici della finanza speculativa e l’impiego di tutte le risorse delle Banche Centrali, capaci di creare denaro – ma non valore – dal nulla non riescono a venire a capo.
Il crollo delle Borse mondiali, iniziato nelle piazze asiatiche nelle scorse settimane ed estesosi ora a tutto il mondo occidentale, da Wall Street ai mercati finanziari europei (Milano, “centro epidemico”, è addirittura sprofondata fino al record negativo di tutti i tempi: -17% in un solo giorno, ma anche Londra, Francoforte, Parigi e New York hanno subito perdite pesantissime), segnala con una potenza dirompente che una nuova edizione della crisi sistemica del capitalismo mondiale bussa alle porte, ridicolizzando le letture minimaliste che appena qualche giorno fa i portavoce del capitalismo globale si affannavano a proporre.
L’Interim Economic Outlook dell’OCSE, ad esempio, prevedeva un rallentamento dell’economia mondiale dal 2,9% al 2,4% e manteneva previsioni ottimistiche per il PIL mondiale del 2021, confermando che le analisi degli organismi internazionali, più che “prevedere” gli avvenimenti, si sforzano di influenzarli, condizionando i comportamenti dei soggetti economici.
Ma evidentemente qualcosa non quadrava in questo affresco, se nel suo The world economy at risk la stessa OCSE ipotizzava anche un possibile dimezzamento della crescita (1,5%) in un quadro di “alta incertezza dell’economia mondiale”.
E uno dei principali esponenti di tali organismi Kenneth Rogoff – ex capo economista del FMI e membro del board della FED – si è spinto a parlare di recessione mondiale, evocando lo shock petrolifero del 1973.
Per quanto il parallelo col 1973 suoni beffardo, vista la situazione opposta del prezzo del greggio allora ed oggi, il sentore di un crash incombente si è dunque affacciato anche in esponenti qualificati dell’establishment.
Sta di fatto che i fattori di crisi si sono accumulati rapidissimamente nell’economia, richiamando scenari drammatici.
Ancora una volta, è bastato poco per mettere in moto una reazione a catena micidiale, di cui stiamo vedendo l’esordio e di cui nessuno conosce la reale portata e il possibile punto di arrivo.
Quello che è certo è che il meccanismo stesso di propagazione della destabilizzazione economica mostra un sorprendente parallelismo con la dinamica di contagio del virus che ne ha costituito il detonatore “esterno”.
Se ciò avviene è perché nella riproduzione del capitale complessivo i materiali infiammabili pronti ad incendiare la prateria alla prima occasione non solo non sono stati eliminati, ma si sono ulteriormente accumulati.
La “grande crisi” che le classi dominanti di tutti i paesi dichiaravano essere ormai definitivamente alle spalle è stata in realtà superata (o tamponata) senza rimuoverne i fattori scatenanti, anzi con il loro rafforzamento.
Dodici anni fa, l’intervento massiccio delle Banche Centrali di tutti i principali Stati salvò un sistema finanziario mondiale ormai virtualmente in default, inondando l’economia di moneta, sostituendosi alle banche commerciali ormai paralizzate e mantenendo tassi d’interesse estremamente bassi, quando non addirittura negativi, come nel caso della BCE.
Questo fatto, se ha evitato la deflagrazione del sistema economico, ne ha però ulteriormente rafforzato la finanziarizzazione, sebbene economisti accademici e agenti del capitale in varie vesti si siano sforzati di dire che la causa della crisi era da ricercare nella finanza “senza regole” non più al servizio della cosiddetta “economia reale”.
Questo è uno dei nodi che oggi vengono al pettine in questa nuova crisi.
L’economia mondiale degli ultimi anni ha beneficiato appunto di tassi prossimi allo zero e di una copiosa liquidità assicurata dalla Banche Centrali, o direttamente (come nel caso della FED, della Banca d’Inghilterra, della Banca Centrale giapponese) o indirettamente, come nel caso della BCE, che ha fatto lo stesso con il quantitative easing di Draghi, che ha aggirato i vincoli statutari su cui è stato costruito l’edificio dell’euro.
E’ questa politica monetaria che ha permesso a tutte le principali imprese mondiali di indebitarsi in modo massiccio.
Il Sole 24 Ore del 10 marzo riporta un dato assai significativo: attualmente, l’indebitamento delle sole aziende non finanziarie globali ammonta a 74.000 miliardi di dollari, pari al 94% del PIL mondiale.
Un indebitamento di simili proporzioni, va da sé, è una mina pronta ad esplodere non appena qualcosa vada storto, sia esso un calo dei profitti, un innalzamento dei tassi di interesse, un qualunque fattore di instabilità che modifichi in senso sfavorevole la congiuntura.
In tutte le grandi corporations, anche quando si parli di imprese industriali, è cresciuta enormemente la dimensione finanziaria e speculativa.
Esse non si limitano a gestire speculativamente le eccedenze valutarie, cioè il capitale monetario temporaneamente inattivo, ma spostano sul terreno finanziario quote crescenti dei profitti generati nel processo produttivo, creando proprie divisioni ad hoc, che non di rado si trasformano nel vero core business dell’azienda.
E’ un processo irreversibile, che dal superamento della crisi del 2007/2008 ad oggi si è ulteriormente rafforzato, utilizzando i canali bancari, il mercato obbligazionario, la speculazione sui titoli derivati.
Lo stesso processo coinvolge anche le imprese finanziarie, gli istituti di credito, il sistema bancario-ombra costruito attorno al mercato OTC, gli hedge funds, ecc.
L’epidemia in corso ha dato il via ad un sommovimento che scuote questo enorme castello di debiti, prospettando l’avvio di un catena paurosa di default a scala internazionale, complice lo stallo del mercato obbligazionario, la vulnerabilità del sistema bancario – nonostante i numerosi interventi, succedutisi in questi anni, volti a puntellarne la stabilità – e l’interruzione forzosa dell’intera catena dell’approvvigionamento di liquidità e di finanziamento delle imprese.
Presagendo queste scosse telluriche, la FED ha tentato di giocare d’anticipo, tagliando i tassi fino all’1-1,25%.
Wall Street ha ringraziato, ma subito dopo ha continuato la sua corsa verso il basso, a dimostrazione che una sforbiciata dei tassi non basta a raddrizzare la situazione.
Del resto, sel’intervento della FED ha mostrato la sua inefficacia (Trump avrebbe voluto un taglio ancora più deciso), una situazione peggiore attanaglia la BCE, dal momento che i tassi d’interesse nel vecchio continente sono già negativi e quindi la politica monetaria ha un margine d’azione praticamente nullo.
E lo si è visto chiaramente alla prima occasione in cui la Lagarde è dovuta intervenire, con l’effetto di accentuare al massimo (il 12 marzo) la rovinosa caduta delle borse europee (tutte).
La guerra del petrolio
L’ulteriore elemento devastante è la guerra del petrolio scoppiata fra la Russia e l’Arabia Saudita.
Con un prezzo del barile crollato a poco più di 30 $ (come durante la prima guerra del Golfo), sono tracollati i titoli delle compagnie petrolifere, trascinandosi dietro gran parte dei listini di Borsa e accelerando la corsa verso i beni-rifugio. Non a caso, l’oro ha superato i 1700 $ l’oncia per la prima volta in sette anni e, contemporaneamente, sono calati ai minimi i tassi pagati dai Treasury Bond decennali (considerati i più sicuri) per la corsa ad accaparrarseli, che ne ha fatto lievitare il prezzo di acquisto, deprimendone per ciò stesso i rendimenti.
I grandi operatori del mercato, gli squali delle Borse e i gestori di fondi, compresi gli hedge funds abituati a lucrare sui rischi e le speculazioni, hanno iniziato a puntare altrove, fuggendo anche dal mercato delle obbligazioni societarie, che si è praticamente paralizzato.
I titoli delle compagnie petrolifere legate alla produzione di shale oil (quello estratto con la tecnica del fracking) hanno registrato perdite dal 40% all’80%. Ma non si tratta solo di temporanei cali delle quotazioni azionarie, bensì di un tracollo della redditività che ne mette in forse la stessa esistenza, e rischia di trasmettersi piuttosto rapidamente anche alle banche che le hanno finanziate – con evidenti effetti anche sulla politica statunitense e la stessa rielezione di Trump.
I costi di estrazione del greggio per OPEC e Russia sono più bassi di quelli americani e infatti la produzione autoctona statunitense ha sempre conosciuto uno stop and go legato ai prezzi e alla domanda internazionale.
Laddove quest’ultima può essere soddisfatta solo grazie al quantitativo immesso dai produttori yankee, i prezzi sufficientemente alti remunerano anche le condizioni peggiori di produttività.
Ciò determina la formazione di una rendita differenziale per i paesi dell’OPEC e, allo stesso tempo, consente alle aziende USA, gravate da maggiori costi di produzione, di ricavare quantomeno il profitto medio, cioè un profitto “normale” se rapportato al capitale da loro investito.
Questo meccanismo è tanto più valido per lo shale oil, che ha costi di estrazione ancora più elevati e quindi abbisogna di prezzi internazionali sufficientemente alti da renderne conveniente lo sfruttamento.
L’attuale guerra petrolifera (in cui, a sparare per prime sono state proprio le compagnie USA del fracking, che hanno sistematicamente compensato i tagli della produzione OPEC e russa con aumenti delle proprie quote) è ricca di implicazioni pesantissime, non solo per i listini di Borsa, ma per la stabilità dell’economia capitalistica nel suo insieme e per lo sconquasso che può produrre nei rapporti di potenza a livello internazionale, nelle alleanze fra gli Stati e negli assetti di un’area cruciale per gli equilibri mondiali come il Medioriente.
La guerra fra Russia e Arabia Saudita sarà senza esclusione di colpi. Le dichiarazioni di Mosca non lasciano dubbi, con il ministro Novak che si è premurato di rilevare come il fallimento dell’intesa con Riad metta fine, da entrambe le parti, alle restrizioni di produzione, insomma un “liberi tutti” che suona come un chiaro avvertimento.
Ed infatti la Russia si prepara alla battaglia, pronta a mettere in gioco le enormi riserve valutarie accumulate dal suo fondo sovrano (le fonti ufficiali parlano di 570 miliardi di dollari) e la volontà/possibilità di lasciar oscillare al ribasso il rublo,dando ulteriore spazio alla competitività delle sue esportazioni di greggio.
Certo, quest’ultima arma va utilizzata con parsimonia, perché il livello di cambio ha conseguenze su tutta l’economia anche sul versante interno.
Un’eccessiva svalutazione del rublo, infatti, potrebbe riaccendere l’inflazione interna, ma anche su questo versante un conto è lo spazio di manovra della Russia, comunque una grande potenza imperialista, un altro quello dell’Arabia Saudita, la cui moneta è dipendente dal dollaro (come la sua sicurezza dal Pentagono) e rispecchia il limitato margine di manovra di uno Stato costruito attorno all’oligarchia finanziaria dei Saud e allo sfruttamento dell’enorme rendita petrolifera (la cui entità è ben misurata dal dato circolato in questi giorni, che dice di una perdita, agli attuali prezzi del greggio, di circa 2 miliardi di dollari al giorno per l’insieme dei paesi OPEC).
L’esaurimento della “spinta propulsiva” cinese
Per quanto sommario, il quadro dei fattori di crisi che convergono verso un nuovo crash del sistema capitalistico mondiale non sarebbe completo se non rilevassimo un altro elemento di grande importanza, vale a dire il rallentamento dell’economia cinese, aggravato violentemente dall’attuale epidemia, ma iniziato ben prima degli ultimi avvenimenti.
Non a caso, il sito Chuangcn.org, a cui rimandiamo per la lettura integrale del testo, in un articolo del 2016, riportava da fonti ufficiali del PCC la profonda preoccupazione dell’establishment di Pechino per una crescita sostenuta dal debito e dagli stimoli finanziari, avvertendo che tali metodi avrebbero potuto condurre il paese verso la catastrofe (compresa la distruzione dei “risparmi popolari”), che la lievitazione e la successiva esplosione di bolle speculative avrebbe prodotto una crisi sistemica, che il problema che si andava ponendo era la riduzione della sovracapacità produttiva attraverso il necessario fallimento delle aziende “decotte”, anche a costo di un periodo di stasi della crescita economica.
Ironia della storia, l’estremo pessimismo nelle alte sfere di Pechino si contrappone all’ottimismo economico di molte analisi qui in Occidente, riprese anche da ambienti militanti, in cui l’economia cinese era/è presentata come un’inesauribile sostegno al processo mondiale dell’accumulazione capitalistica.
La guerra dei dazi avviata da Trump, con le sue conseguenze sul commercio mondiale e sull’inversione del lungo ciclo fondato sull’assoluta liberalizzazione dei movimenti dei capitali, si è inserita dunque come un fattore aggravante di problemi strutturali già presenti nell’economia cinese, problemi che denunciano l’inconsistenza delle interpretazioni fondate sulla pretesa diversità del gigante asiatico e sulla sua funzione di rivitalizzazione delle economie mature.
Al contrario, la Cina ha raggiunto con estrema rapidità i problemi dei vecchi paesi imperialisti, mostrando che il carattere storicamente superato del modo di produzione capitalistico non è una caratteristica che si può “spacchettare” paese per paese, come se ciascuno potesse ripercorrere, in un quadro di pretesa autonomia nazionale, la lunga marcia dalla manifattura ottocentesca al capitalismo finanziario dei nostri anni, ma riguarda il sistema capitalistico mondiale nel suo complesso.
Quando una nazione come la Cina si affaccia nel novero dei paesi più industrializzati dominanti sul mercato mondiale, pur con le contraddizioni che tuttora la attanagliano, ne eredita velocemente anche tutti i mali che definiscono lo stadio imperialistico come ultima fase de capitalismo, quello in cui il sistema economico-sociale di cui la classe dei capitalisti è portatrice, non svolge più alcun ruolo progressivo ma è solo una zavorra reazionaria per l’intera società.
L’epidemia di coronavirus ha amplificato le difficoltà di Pechino, bruciando i tempi del processo.
Né poteva essere diversamente. Wuhan e la provincia dell’Hubei sono fra le più industrializzate
della Cina.
Là sono concentrate molte industrie elettroniche, là si trova il più grande polo automobilistico del paese.
Lo stop delle attività ha inferto un duro colpo alla produzione cinese.
Ma già a febbraio i dati ufficiali parlavano di un Indice composito dell’attività manifatturiera calato ad un valore oscillante, a seconda delle stime, fra 35,7 e 27,8 punti, più basso del livello raggiunto nel 2008 in piena crisi finanziaria mondiale.
Analogo calo nel settore dei servizi.
Sono indici che tengono conto di numerosi fattori: ordini, produzione e consegna delle merci, consistenza delle scorte, ecc. e, per valori inferiori a 50, denunciano una contrazione economica.
Una situazione che già si ripercuote, a ancor più lo farà nel prossimo futuro, sulle catene di approvvigionamento che dipendono dalle forniture cinesi, in misura tanto maggiore quanto più il capitalismo just in time prevede il tendenziale azzeramento delle scorte per risparmiare sui costi di magazzino.
A completare il quadro, va ricordato che la Cina è il maggiore acquirente mondiale di materie prime e energetiche.
Nel 2018 ne ha importate per un valore di circa 500 miliardi di dollari, con un significativo calo, nel 2019, a 300 mld $. Tuttavia, nonostante il calo delle importazioni di materie prime – che avrà un impatto negativo soprattutto per Australia, Brasile e Russia paesi per i quali la Cina rappresenta il “cliente” principale – le esportazioni di Pechino sono calate ben di più, determinando, per la prima volta, un disavanzo commerciale di oltre 7 miliardi di dollari.
Analoghi dati si riscontrano nel diminuito consumo di carbone, anch’esso a segnalare una contrazione dell’attività produttiva.
Nel sottolineare questa dinamica, questa linea di tendenza, e quindi nell’escludere che la Cina possa fungere di nuovo da ammortizzare della crisi globale, come avvenne in parte negli anni dopo il 2008, non escludiamo affatto che, paradossalmente, l’impatto più duro della nuova crisi possa verificarsi sull’Europa (già se ne vedono i segnali) e sugli stessi Stati Uniti.
E se questo dovesse avvenire per davvero, ci siano alla Casa Bianca i repubblicani o i democratici, le tensioni commerciali e tecnologiche tra Cina e Stati Uniti diventeranno ancor più tese di oggi, con gli Stati Uniti costretti, per le logiche proprie del capitalismo imperialista, a colpire ovunque, avversari e alleati, più duramente di oggi.
Solo con mezzi economici e diplomatici?
Il grande rilancio della spesa bellica e dell’industria militare negli Stati Uniti e dovunque lascia la questione aperta, molto aperta.
L’acuirsi dello scontro fra le grandi potenze
L’epidemia di coronavirus ha dunque accelerato e fatto esplodere una nuova crisi economico-finanziaria del sistema capitalistico.
Con una dinamica a cui ci siamo rapidamente abituati, lo sconquasso della produzione di beni e di servizi (dal turismo ai trasporti, dalla ristorazione agli spettacoli) e della finanza investirà tutto il mondo, perché tale è ormai (non solo tendenzialmente, ma immediatamente) l’arena su cui il modo di produzione capitalistico gioca le sue carte.
Non esistono Stati, aree, aggregazioni che possono sottrarsi al dominio pervasivo, e per ora incontrastato, dei rapporti capitalistici di produzione, dei meccanismi del profitto e della valorizzazione del capitale globale.
Rispetto alla crisi del 2007-2008, lo scenario dei rapporti interimperialistici e interstatali è però ulteriormente mutato.
Il declino relativo della potenza USA non permette più l’imposizione di un ordine americano sul mondo.
Le vicende delle guerre neocoloniali in Iraq e Afghanistan stanno lì a sanzionarlo con evidenza: gli USA sono stati in grado di “riportare quei paesi all’età della pietra”, non sono stati in grado, però, di dar vita ad un equilibrio stabile, per quanto basato sullo sfruttamento e il saccheggio delle loro risorse.
Ma se questa capacità di dominio globale è ormai svanita, così non è per la supremazia del colosso yankee, che l’Amministrazione Trump ha deciso di rilanciare, attizzando i conflitti sia con gli Stati nemici che con gli alleati/concorrenti.
Il “sovranismo” trumpiano, che non è la causa del modus operandi di Washington, ma è conseguenza di tali profondi mutamenti, si muove così col chiaro intento di smantellare tutti i fattori che negli anni si sono accumulati ad arginarne azione e ruolo sul mercato mondiale e nello scacchiere internazionale.
Se il nemico strategico resta la Cina, e la guerra dei dazi ha solo costituito l’antipasto di ciò che riserva il futuro, non meno esposta, nell’immediato, è l’UE e il suo progetto – sempre più contraddittorio e problematico – di costruzione di un polo imperialistico capace, in prospettiva, di contendere agli USA la leadership del capitalismo mondiale.
In questa direzione va, ad esempio, il lavorìo pro-Brexit, espressione, ad un tempo, della volontà di infliggere un colpo al vecchio continente e dell’incapacità di mantenere Londra come pedina capace di frenare i disegni europeistici, una strategia che ha preferito l’uovo della separazione della Gran Bretagna dall’UE, oggi, alla gallina, domani, del condizionamento di Bruxelles da parte di Londra.
Ma il ventaglio dei conflitti aperti dalla accresciuta aggressività degli USA include molti altri fronti aperti, dalla Russia, all’Iran, alla stessa Arabia Saudita – non più intoccabile come un tempo – mentre rinsalda al massimo l’identificazione con Israele e la sua volontà di annichilimento totale del popolo palestinese.
Lo Stato sionista, infatti, non rappresenta solo un alleato di ferro per Washington, ma si potrebbe dire una vera e propria talea imperialistica piantata nel cuore del mondo arabo, un avamposto qualitativamente differente da tutti gli altri per tenere sotto controllo l’intero Medio Oriente.
Ed è proprio sul controllo di quest’area cruciale per la stabilità del sistema che le vicende della crisi economica in gestazione andranno ad interferire, crediamo, in modo dirompente.
La guerra del petrolio iniziata fra Riad e Mosca, ad esempio, non tradisce solo la volontà di quest’ultima di assestare un colpo alle compagnie yankee dello shale oil, che insidiano mercati energetici nell’orbita russa, ma la volontà di rinsaldare il quadro delle alleanze nell’area, puntellando l’opera di rafforzamento dello status di super-potenza intrapreso da Putin già da tempo.
E si può star certi che, se perdurasse l’attuale livello delle quotazioni di greggio, la diminuzione delle entrate da rendita petrolifera sarebbe devastante per molte compagini statali e per la loro capacità di fronteggiare gli amplissimi movimenti di massa che ne contestano apertamente il potere ormai da più di un anno.
Non a caso, all’indomani della rottura del vertice OPEC Plus a Vienna, il ministro algerino dell’energia ha lanciato un accorato appello ai contendenti a trovare un accordo sulla questione controversa dei tagli alla produzione.
Ancora una volta, la crisi economica capitalistica e la sua dimensione sistemica si intrecciano profondamente con la crisi dell’ordine di Yalta, ormai da tempo dissoltosi, ma anche con la fine di quella lunga parentesi tenuta a battesimo dalla prima guerra del Golfo e che sembrava rilanciare il predominio assoluto nordamericano.
Si va con tutta evidenza, benché in modo molto caotico, verso la formazione di due schieramenti capitalistici contrapposti, l’uno facente perno sugli Stati Uniti, l’altro sull’asse (sempre più obbligato) Cina-Russia, sempre più apertamente in contesa, con armi e metodi differenti, in ogni angolo dell’economia mondiale.
Contrapposti, ma entrambi ugualmente interessati allo schiacciamento delle masse, a garantire con ogni mezzo la stabilità del sistema e la continuità dello sfruttamento del proletariato.
Sicché per il proletariato cosciente di sé non c’è alcun “meno peggio” da preferire.
Le prospettive dello scontro di classe
Con tutta probabilità, la recessione alle porte sarà una pandemia economica che investirà come uno tsunami l’ordine capitalistico mondiale.
Come abbiamo già detto, è questa la scala a cui si muovono ormai le trasformazioni del modo di produzione capitalistico e gli sconvolgimenti del suo ordine, un ordine puntellato da una dose crescente di militarismo verso le periferie del sistema e di repressione e disciplinamento sociale nelle metropoli dell’imperialismo ultrasviluppato (l’uso che si sta facendo della crisi da Covid-19 è un vero e proprio campo di sperimentazione in questa direzione).
Per quanto le classi dominanti di tutti i paesi si muovano pragmaticamente, senza un “piano scientificamente preordinato”, ma rispondendo agli input trasmessi dalle contraddizioni del sistema capitalistico, ciò non significa che esse siano in balìa degli eventi.
Al loro interno, maturano comunque quelle linee d’azione che – pur scaturendo dagli interessi contrastanti delle varie frazioni borghesi – riescono però, l’esperienza insegna, a trovare sintesi provvisorie, capaci di centralizzare gli interessi di tutti gli strati di sfruttatori, finalizzate allo schiacciamento del proletariato, alla sua sottomissione sociale e politica, alla contrapposizione delle sue componenti interne per annichilirlo come classe indipendente.
Tuttavia, anche se non siamo certo in una fase di conflittualità generalizzata, in particolare in Italia dove la conflittualità immediata è a livelli molto bassi, gli attuali avvenimenti non potranno che accentuare la polarizzazione sociale, una polarizzazione che è già esplosa nelle periferie del sistema (“periferie” sterminate, però, che vanno dall’America Latina al Maghreb al Medio Oriente) anche se ancora fatica a manifestarsi qui da noi, nel cuore della bestia.
Per la classe capitalistica, la polarizzazione dello scontro sociale rappresenta un rischio di cui i più avvertiti fra i suoi rappresentanti sono coscienti e che si sforzano di prevenire e neutralizzare.
Ai rivoluzionari spetta il compito di organizzarsi e muoversi almeno con lo stesso livello di consapevolezza dei nostri nemici di classe, cominciando a serrare le fila al nostro interno e a prospettare alle avanguardie di lotta della nostra classe una strategia che si muova alla stessa scala di quella del sistema che vogliamo rovesciare.
Alla crisi mondiale dell’ordine capitalistico è giocoforza rispondere con una strategia che abbia lo stesso respiro e che sia internazionalista nei suoi fondamenti teorici e di principio ma anche, inseparabilmente, nel suo piano di battaglia politica concreta.
Se qualcosa emerge con chiarezza dagli avvenimenti attuali è che ogni prospettiva che si pretende di classe e anticapitalistica, ma continua a muoversi sul terreno del localismo, del piccolo cabotaggio, cullandosi nell’illusione che sia possibile contrastare il rullo compressore dell’offensiva borghese strappando qua e là brandelli di “autonomia”, non può che avere un effetto disarmante sul movimento delle lotte, contribuendo alla loro sconfitta.
La dimensione mondiale della crisi ci dice con chiarezza che non esistono percorsi di liberazione chiusi dentro confini nazionali, e men che meno locali e localistici, per il proletariato.
La classe capitalistica di ogni paese si muove nel quadro di un sistema di relazioni globali, e da queste è strettamente condizionata.
Il proletariato, e i rivoluzionari per primi, ne devono prendere coscienza, rompendo con ogni prospettiva angustamente nazionale o “sovranista”, che ipotizzi la possibilità di avanzare sul terreno dell’emancipazione di classe appoggiando questa o quella “soluzione della crisi” che faccia perno su una pretesa convergenza transitoria di interessi con gli sfruttatori di casa nostra.
Questo vale per chi, ad esempio, parla di uscire dall’euro e riconquistare la “nostra” sovranità monetaria quale precondizione per meglio difendersi e così facendo capitola di fronte al nazionalismo, che è precisamente il terreno su cui le classi dominanti concentrano la loro iniziativa per serrare le fila e imporre una subordinazione ancora più dispotica agli interessi dei padroni e del loro Stato.
E’ evidente che, a dispetto delle differenze retoriche e di facciata fra “progressisti” e “populisti”, in Italia tra governo Conte-bis (Pd-Cinquestelle) e opposizione di destra, entrambi gli schieramenti marciano a ranghi compatti per martellare nelle coscienze dei proletari che non esiste possibilità alcuna di sopravvivenza se non rilanciando l’unione sacra fra classe capitalistica e proletariato, che la nazione deve compattarsi, oggi, per difendersi dall’epidemia in corso, e domani per reggere lo scontro economico, e in prospettiva militare, con “i nostri nemici”.
Anche la lotta fra questi due schieramenti, entrambi integralmente reazionari, sarà decisa non nel cortile di casa nostra, ma in rapporto allo scontro più generale che va maturando nello scenario mondiale e verificando quale delle differenti politiche di asservimento del proletariato sia in grado di offrire più chances di successo alla borghesia.
Se il “sovranismo di sinistra” esce sconfitto e ridicolizzato dagli attuali avvenimenti, ciò non significa affatto che il sovranismo tout-court – quello iper-capitalistico delle destre cosiddette “populiste” – abbia bruciato tutte le sue carte.
Su questo terreno, l’evoluzione della crisi e la riaccensione della lotte degli sfruttati potrebbe anche imporre alle classi dominanti misure straordinarie, capaci anche di colpire qualche limitato privilegio delle classi possidenti con l’obiettivo di consolidare la stabilità complessiva del sistema capitalistico.
Le destre apertamente reazionarie, quelle che per esperienza storica sanno miscelare demagogia popolare, critica alla rapacità della finanza e richiami all’ordine, ma anche una sinistra socialdemocratica un po’ meno inginocchiata ai piedi delle grandi banche di quella italiana di oggi, giocheranno proprio questa partita.
E quindi l’unica risposta possibile ai disastri di ogni tipo prodotti dal sistema capitalistico, l’unica risposta possibile all’offensiva che gli sfruttatori e le forze politiche al loro servizio stanno preparando per scaricare sui lavoratori e sulle lavoratrici le conseguenze di questi disastri, è che le classi lavoratrici scendano in campo in massa, si difendano accanitamente dall’aggressione alle loro condizioni di vita e di lavoro, e alla fine presentino loro il conto storico e definitivo a questo sistema sociale in putrefazione.
Su questo percorso di lotta e di uscita dall’attuale stato di nullità politica, a cominciare dai compiti di lotta più immediati per salire a quelli di prospettiva, abbiamo detto qualcosa nel documento sulla crisi del coronavirus.
Non ci ripetiamo.
Quanto ai professionisti del disfattismo anti-rivoluzionario a cui piace irridere la nostra incrollabile certezza nella riscossa del proletariato, si becchino per il momento la sberla della forte agitazione operaia scoppiata in questi giorni in tante fabbriche contro l’imposizione padronale di lavorare sempre e comunque a rischio della salute e della vita.
Il resto verrà, per loro e soprattutto per i loro soprastanti – e verrà non con una dinamica di accumulazione delle forze lentissima e “secolare”, ma con una progressione esponenziale simile a quella con cui ci è piombata addosso questa nuova crisi.
La sola cosa che qui ci preme ripetere, e che non ci stancheremo di ripetere per la sua importanza decisiva, è che davanti ad una crisi che si preannuncia ancora più globale di quella del 2008, la sola forza su cui il proletariato italiano, autoctono e immigrato, potrà contare è quella degli sfruttati e delle sfruttate di tutti gli altri paesi del mondo.
Ed è una forza che, se organizzata e cosciente, se autonoma da entrambi gli schieramenti capitalisti-imperialisti in formazione, è in grado di travolgere qualunque ostacolo.
Gettate un occhio sulle grandi manifestazioni dell’8 marzo in Cile, in Messico, in Algeria, fate mente locale sul ritorno in campo delle sollevazioni delle masse arabe nel 2018-2019, sul seguito di forti lotte proletarie e popolari in Francia, e ne avrete degli assaggi in tempi in cui le temperature sociali non sono ancora bollenti…
13 Marzo
Il Cuneo rosso – Gcr – Pagine marxiste
Tendenza internazionalista rivoluzionaria
Laboratorio politico Iskra